Sant’Antonio di Ranverso I Cimiteri prima della riforma di Napoleone
Sant’Antonio di Ranverso I Cimiteri prima della riforma di Napoleone
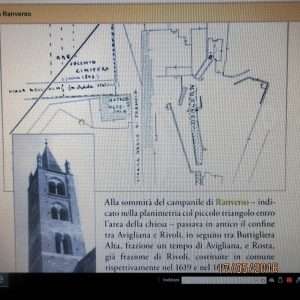
L’Editto di Saint-Cloud emanato da Napoleone Bonaparte
Prima della pubblicazione dell’editto di Saint-Cloud, voluto da Napoleone Bonaparte nel 1804, esteso all’Italia nel 1806, si era soliti seppellire i defunti, specie quelli di ceto elevato e quelli religiosi, all’ interno delle Chiese o nelle immediate vicinanze, quasi a voler impetrare la protezione divina sui morti.
La motivazione di tale decisione era duplice: in primo luogo era dettata da motivi igienico e sanitari e di salute pubblica, in quanto il continuo seppellimento dei defunti nelle chiese, spesso in tombe non ben tenute, come vedremo nella successiva documentazione, procurava dei problemi di olezzo, di effluvi contagiosi e possibilità di contrarre malattie. In secondo luogo era dettata da una finalità ideologico-politica, quella del rispetto di quell’ uguaglianza dei cittadini, obiettivo conseguito a seguito della Rivoluzione francese.Quasi tutte le Chiese disponevano al loro interno di numerosi altari gentilizi o piccole cappelle, nelle quali erano sepolti i componenti di quella famiglia.
Napoleone, dunque, dispose il divieto di seppellire i defunti non solo all’ interno delle Chiese, templi, sinagoghe, ospedali, cappelle pubbliche o luoghi chiusi dove i cittadini si riunivano per la celebrazione dei loro culti, ma anche all’ interno delle città. I cimiteri dovevano essere costruiti almeno alla distanza di 35-40 metri dalle città, su terreni espressamente consacrati per l’inumazione dei morti. Dovevano essere costruiti in posizione elevata, esposti a nord in luoghi soleggiati ed arieggiati per garantirne la ventilazione da eventuali cattivi odori ed essere cinti da mura di almeno due metri di altezza
La conversione al Cristianesimo e le sepolture urbane
I Longobardi non furono da sempre una popolazione cristiana; in origine infatti praticavano il paganesimo e veneravano divinità femminili legate alla fertilità e alla terra.
In seguito al contatto con altre popolazioni germaniche adottarono il culto di divinità maschili di ispirazione guerriera.
Con il trasferimento in Italia e il contatto con la civiltà romana i Longobardi si convertirono progressivamente al cattolicesimo fra il VI e il VII secolo.
La fede nella resurrezione cristiana comportò quindi la scelta di seppellire i morti invece che cremarli, dal momento che il credente in Cristo sarebbe risorto con il proprio corpo. Tuttavia cimitero di Sant’Anastasio non testimonia soltanto la conversione dei Longobardi, ma anche di un fenomeno che si sviluppa nel corso del Medioevo e che vede lo spostamento dei cimiteri all’interno della città.
In precedenza erano infatti proibite dalle leggi romane le sepolture dei defunti entro le mura cittadine; le aree cimiteriali sorgevano immediatamente al di fuori del centro urbano, lungo i lati delle strade che conducevano alle porte urbiche.
Le dimore dei morti erano dunque tenute rigorosamente separate da quelle dei vivi, anche in funzione della tutela dell’igiene pubblica. L’adozione di questa nuova pratica segna quindi una radicale trasformazione che avrà profonde ripercussioni sulla concezione in età medievale della morte e sulla sempre maggiore familiarità con essa, associata tra l’altro al culto dei martiri, come nel caso astigiano, e delle loro tombe. Inoltre verrà meno la salubrità stessa degli agglomerati urbani, per secoli tutelata dalle leggi romane.

