CEGLIE, GLI STEMMI ARALDICI
CEGLIE, GLI STEMMI ARALDICI
di Pasquale ELIA
I Comuni medioevali assunsero insegne araldiche appena conseguirono una personalità giuridica ed un assetto politico-amministrativo.

Le città si dividevano in quartieri, talora detti porte o rioni che a loro volta scelsero particolari bandiere o gonfaloni; le rispettive figure furono scolpite o dipinte sulle porte fortificate, sui palazzi civici e sui portoni patrizi ed, in seguito, anche sui frontali e sui cancelli dei Cimiteri Monumentali.
Il primo stemma di Ceglie era costituito da un castello chiuso sormontato da tre torri chiuse.
S’ignora quando quel primo stemma sia nato. Possiamo congetturare che esso sia stato ideato subito dopo la costruzione del castello da parte dei primi feudatari, presumibilmente, tra il 1050 e il 1100 ed è rimasto in uso fino all’abolizione della feudalità. Lo scudo in argomento, scolpito su pietra locale, fu murato sulla facciata del carcere (attuale Piazza Vecchia) fatto costruire, nel 1568, da Giovanni Giacomo Sanseverino, IV conte della Saponara (odierna Grumento Nova in provincia di Potenza).
Il sigillo, infatti, datato 1752, rintracciato presso l’Archivio di Stato di Napoli dall’amico Michele Ciracì, riproduce fedelmente quella prima arma. L’unica differenza è l’aggiunta di una corona a tre punte.
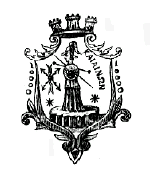
Con l’abolizione della feudalità, l’Università cegliese, nel 1812, si dà una nuova arma, tra l’altro, elimina anche il predicato Gaudo. Trattasi di una torre rotonda chiusa a tre merli e su di essi un’aquila imperiale a volo spiegato con capo rivolto a sinistra. I merli sono del tipo guelfo, mentre l’odierno stemma ha i merli errati perché del tipo ghibellino. Si intendono guelfi quando hanno il profilo superiore rettilineo (guardare i merli della torre).
Nel 1864, forse, per dare maggiore lustro e credibilità al predicato Messapico, fu scelto uno stemma rappresentante, un guerriero messapico e non la Minerva Galeata come qualche storico locale afferma. Esso è così composto. In campo azzurro con figure in nero. Corona formata da tre torri aperte a tre merli ciascuna, guerriero con elmetto tipo corinzio con cimerio, armato con due lance, faretra con frecce, due saette, due stellette a otto punte e scritta in caratteri greci Kaiainon.
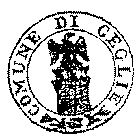
La parola in greco doveva essere KAILINON, con il suono di Kailinon da Kailìa, e non Kaiainon come invece compare sullo stemma. Con molta probabilità quando la parola fu riprodotta sul sigillo, l’esecutore credette che fosse una A italiana anziché una L greca.
Nella riproduzione del 1939 la parola Kailinon fu riprodotta in modo corretto.
Nella rampa delle scale d’ingresso della vecchia Questura di Brindisi, ora Uffici Amministrativi della Prefettura – Piazza Dante – ricordo che non molti anni fa erano riprodotti sul muro tutti gli stemmi araldici dei venti Comuni componenti la provincia di Brindisi, istituita il 7 gennaio 1927. A quanto mi risulta, le scale di cui sopra non sono aperte al pubblico, per arrivarci, infatti, si deve passare attraverso l’ingresso principale della Prefettura in Piazza Santa Teresa.
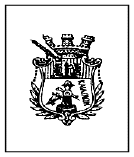
Con l’avvento del fascismo tutti gli Enti pubblici dovettero fregiarsi anche del fascio littorio. Dapprima, sulla documentazione ufficiale comunale comparvero i due stemmi, quello cegliese e il fascio littorio. In seguito il nostro guerriero fu rimpicciolito, gli fu tolto l’elmo corinzio con cimerio e sostituito da un elmetto tipo inglese, scomparvero le saette, le frecce e le stellette e al loro posto riprodotto una specie di straccio appeso ad un’asta. Tra la testa del guerriero e le tre torri fu inserito il fascio littorio con corone di alloro.
Con la dichiarazione di armistizio dell’8 settembre 1943, fu malamente cancellato il fascio e rimase il guerriero, a mio avviso, mutilato, gli fu sostituito l’elmetto da un cappello con una specie di penna. Anche su questo non ci sono più le frecce e le saette, ma compare una specie di animaletto.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 1953 fu assegnato l’attuale blasone.
Il Gonfalone, invece, fu assegnato con DPR 24 marzo 1981. Infine, con DPR n°4136, in data 13 settembre 1988, Ceglie Messapica fu autorizzata a fregiarsi del titolo di CITTA’.
di Pasquale ELIA
* La porta principale, detta Porta di Juso, nel linguaggio parlato port’ius‘, con il passare degli anni diventeràPorta di Giusoè rivolta ad oriente. Altre due porte, delle quali l’una detta Porticella (posterula), nel linguaggio paesano purtuscèdd‘, popolarmente conosciuta del Monterrone, rivolta a Nord, l’altra denominata Porta dell’Arco della Croce, rivolta a Sud. Quest’ultima fu abbattuta quando, nei primi anni del secolo scorso, la città incominciò ad espandersi oltre le mura medioevali.
A proposito di mura, parte di queste furono rifatte, nel 1809, per …difendersi da eventuali malintenzionati… questo il termine usato dagli Amministratori comunali. Per la cronaca, fino a tutta la prima metà dell’Ottocento, le porte della città venivano chiuse nelle ore notturne.
A quel tempo, per invogliare la popolazione a costruire civili abitazioni fuori le mura il Sindaco dell’epoca (Notaio Caliandro Giannantonio) concesse suolo edificatorio in enfiteusi perpetua, nella zona detta Chianchizze ad un certo Vincenzo Sportelli di Putignano, da più anni residente a Ceglie e a mastro Domenico Palazzo di detta Terra….
La porta di Juso era così denominata dai Padri domenicani dell’omonimo convento. Il termine dalla parola latina Jus ha il significato di diritto. Essa era ed è la porta più piccola, la più semplice dal punto di vista architettonico e anche la più frequentata; era, infatti, la porta dove veniva riscossa la tassa per chi volesse accedere in città.
Ma il suo esatto significato deriva dall’avverbio di luogo giuso (sec.XIII –XVI), latino tardo jusum e josum con il significato di volgere, propriamente volgere in basso; è la porta della città infatti da cui si raggiunge la parte più in basso del territorio.
Sopra la porta si intravede un vano (il corpo di guardia?) al quale si accede dall’interno della cinta medioevale e dove prendeva certamente posto la sentinella. La porta immette direttamente sull’allora piazza principale del paese, oggi nota come Piazza Vecchia. Antica piazza questa dove, fino a non molti anni fa, si svolgeva la vita sociale cittadina. Era il luogo in cui al mattino, di buon’ora, si radunavano i contadini prima di essere assunti dal padrone per il lavoro nei campi.
La domenica, di buon mattino, tra l’altro, nella piazza in questione, era un incrociarsi di dialetti e di rumori vari, si preparava infatti il consueto mercatino settimanale, con la partecipazione di molti commercianti ambulanti provenienti dai paesi circostanti. A questo si aggiungevano i rintocchi della campane delle Chiese (San Domenico, San Demetrio e Chiesa Madre, raramente anche Chiesa di Sant’Antonio Abate ed Annunziata) che richiamavano i fedeli alla celebrazione del Sacro Rito. Con l’espansione della città fuori la cinta muraria, fu necessario trasferire anche il mercato settimanale verso i nuovi quartieri, Mammacara, San Rocco. Infatti fu portato in Piazza Sant’Antonio, via San Rocco, via Martina, Corso Verdi. Una trentina di anni fa poi, fu anticipato al sabato e spostato nella zona di Corso Verdi, infine dove attualmente si svolge.
Nella piazza in argomento si affacciava il carcere cittadino fatto costruire nel 1568 dal barone Giovanni Giacomo Sanseverino, IV conte di Saponara; insisteva un orologio meccanico posto in cima ad una torretta quadrata, recentemente abbattuta; c’era la sede della gendarmeria la quale fu in seguito trasferita nei locali del convento dei domenicani.
Il 10 maggio 1865, dopo alcuni lavori di ristrutturazione, im quella sede fu costituita la Caserma dei Regi Carabinieri a piedi il cui suo primo Comandante fu il brigatiere Pietro Perina. Nella piazza aveva sede anche la Bagliva che già il 26 aprile 1824, con delibera decurionale assumeva il nome di guardie campestri.
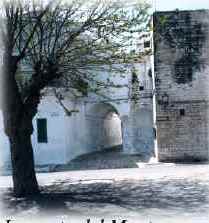
l’accesso, a portone chiuso, ai soli pedoni, attraverso una porticella (murata ma ancora ben visibile), posta sul lato destro;
di esercitare una più capillare azione di controllo su chi entrava;
un più spedito transito agli animali da soma muniti di basto (asini o muli) e raramente anche carretti.
Sul lato sinistro della porta, sorge una torre, forse più volte ristrutturata negli anni, la quale si innalza per un‘ altezza di 7-8 metri. La torre ospitava il Corpo di guardia, locale utilizzato dal personale di vigilanza per riposare e depositare e custodire le armi. Sopra la costruzione prendeva posto la sentinella.
Mi preme fare alcune precisazioni sul significato di alcune raffigurazioni, dipinti o affreschi posti nelle immediate vicinanze delle porte. Sono quanto rimane di un antico rito di benedizioni dei campi, che prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II si compiva ovunque.
Il 25 aprile o nei due giorni immediatamente successivi, il clero, in questo caso il Capitolo della Chiesa Madre, si recava processionalmente alle porte della città nel suggestivo rito delle Rogazioni. Erano le invocazioni rivolte a Dio per chiedere la benedizione dei campi e del raccolto. Dopo la benedizione veniva posta una croce-ricordo. In seguito, nei primi anni dello scorso secolo, la benedizione die campi veniva effettuato : una in Via Martina angolo via Ovidio, dove fino ad una quarantina d’anni fa esisteva ancora un monumento con la croce, due, in largo Colucci. Successivamente il 25 aprile fu dedicato a San Marco. I sacerdoti poi ritornavano in chiesa per la Messa propiziatrice delle Rogazioni. Le Rogazioni si affermarono in Gallia ed in Italia a partire dal VI secolo, e non furono altro che un fenomeno di evangelizzazione di un culto agricolo.

E’ noto che non tutte le strade del Borgo antico erano adatte al passaggio di carri.
La conformazione orografica del terreno su cui si estende la città antica, l’idea di sfruttare al massimo gli spazi disponibili, la difficoltà pratica, a quei tempi, di livellare il terreno roccioso e ripido, sconsigliava l’uso di quel veicolo (a ruote piene e con cerchio in ferro) molto pesante.
Eppoi, le stradine così piccole e strette non consentivano il passaggio ed il parcheggio notturno ai carri, quindi, per il motivo di cui sopra si sviluppò l’uso del basto, certamente più maneggevole per l’uomo e soprattutto meno pesante per l’animale che carico di prodotti della terra o di legna da ardere doveva superare non facili dislivelli (salita del Monterrone e l’odierna via Bottega di Nisco).
Era escluso il cavallo perché meno resistente dell’asino e del mulo su quel terreno accidentato come il nostro e anche animale di stazza più ingombrante nelle stalle-abitazioni. Molto spesso la porta della casa era troppo piccola per fare passare la mole di un cavallo.
Le stradine erano e sono lastricate in modo che l’animale carico del basto, con ferri agli zoccoli e condotto a mano, percorrendo il centro della strada, non potesse scivolare con il pericolo di rompersi una gamba.
Quel tipo di pavimentazione era senz’altro utile anche per gli uomini i quali, fino a meno di quarant’anni fa erano soliti riempire la parte inferiore e il bordo esterno delle scarpe da lavoro con grossi chiodi, mentre alle cosiddette scarpe della festa, per coloro che potevano permetterselo, venivano inchiodati salvatacchi e salvapunte rigorosamente in metallo.
A titolo di cronaca, negli anni Quaranta anche ai quadrupedi, al tiro di carretti (all’epoca erano gli attuali autocarri) con carichi (uve, olive, fichi, grano, masserizie, ecc.) che dovevano percorrere strade cittadine lastricate (erano poche) o extraurbane asfaltate (Ostuni-Ceglie-Francavilla) venivano calzate una specie di scarpa ricavata da vecchi copertoni d’auto.
Gli abitanti che avevano l’abitazione nelle immediate vicinanze della purtuscèdd’, volgarmente conosciuta de il Monterrone, dovevano…..gettare……….le sue mondezze, lo romato e staglio nei luoghi stabiliti dall’Università, cioè fuori la porticella, dove si dice del Monterrone…….
* La Porta dell’Arco della Croce (ora abbattuta) si trovava all’inizio dell’attuale via Giuseppe Elia, già Via Municipio, angolo Piazza Plebiscito.
Veniva usata, principalmente, dalla famiglia ducale. Il corpo di guardia che abbiamo localizzato nelle altre due porte, in questa era dislocato nella torre rotonda posta a sinistra di chi accede da Piazza Plebiscito su via Pietro Elia e sulla cui sommità prendeva posto la sentinella.
Anche questa sentinella aveva un settore di osservazione con un angolo di oltre 180°. Ma la cosa più importante è che le sentinelle delle tre porte si integravano a vicenda. Ciascuna vedetta, infatti, sovrapponeva il suo settore di vigilanza su gran parte di quello di competenza della sentinella attigua. In tal modo la sorveglianza, era per così dire, raddoppiata e quindi difficilmente poteva sfuggire l’avvicinarsi di un qualsiasi nemico od amico che fosse.
L’accesso alla torre, riservato al personale di vigilanza, era dato da una porta, ora murata, ancora ben visibile in via Pietro Elia.
La sorveglianza nella direzione Nord-Ovest (Sant’Anna), Ovest (San Rocco-Fedele Grande), veniva assicurata, con molto probabilità, con una sentinella posta sulla sommità della torre di stile aragonese posta all’interno dei giardini.
In particolari momenti di emergenza la sommità della torre normanna, alta intorno ai 35 metri, diventava un punto di osservazione eccezionale.
STORIA DELLA “CURSIA” (odierno CORSO GARIBALDI)
di Pasquale ELIA
Fin da ragazzino ho sempre creduto che cursìa fosse il vocabolo dialettale derivante da Corso. Quella parola nel gergo paesano (jint’a’cursij), infatti, indica il Corso Garibaldi. Non è invece così.
La Curia oritana con un decreto datato 22 agosto 1748 autorizzava il Capitolo della Chiesa Collegiata (allora) di Ceglie ad alienare, tra l’altro, alcuni beni stabili di proprietà per estinguere un debito di 4.000 ducati dovuti dal Capitolo stesso ad un certo don Giovanni Polaja di Martina. In quell’atto compare il termine Corsèa Sant’Antonio.
La cursìa, corsèa o corsìa (Dizionario Etimologico Italiano, Istituto di Glottologia, Università degli Studi di Firenze, Firenze 1968, a cura di C. Battisti e G. Alessio), sono parole con il significato di corridoio, camerata, ospizio, dormitorio, complesso con letti, insomma l’odierno noto significato di corsìa di ospedale.
Per quanto sopra devo dedurre che nell’odierna Piazza Sant’Antonio o immediate sue vicinanze, alcuni secoli fa, oltre alla piscina di proprietà della Chiesa Madre concessa in censo alla famiglia ducale (all’epoca del documento Sisto y Britto), doveva esserci un ospedale, extra moenia, certamente, per malattie infettive o per malati incurabili dedicato a Sant’Antonio.
Ma quale Sant’Antonio? Da Padova o Abate? E’ noto a tutti che fino a qualche decennio fa esisteva in questa città anche un’antica chiesetta consacrata a Sant’Antonio Abate.
Secondo Rocco Antelmy, primo storico cegliese, quella antica Chiesa potrebbe addirittura risalire all’epoca di Costantino (editto di Milano, 313 d.C.), per avere su di un’architrave della porta d’ingresso incise le lettere IHSV (In Hoc Signo Vinces).
Se volessimo tenere per vero ciò che scrisse Rocco Antelmy circa le lettere I.H.S.V. la devozione per Sant’Antonio Abate nella nostra città potrebbe essere più antica di quanto si crede. E’ storicamente provato che il culto per il Santo si diffuse in Occidente nel V secolo.
Perché non pensare che Ceglie, d’altronde, geograficamente molto vicina all’Impero d’Oriente, possa avere accettato il culto di quel Santo fin dal primo momento? Ma per primo momento dobbiamo intendere dal V secolo in poi e non prima.
Dai documenti custoditi presso l’Archivio di Stato di Brindisi si ricava che già nella prima metà del ‘500 Ceglie possedeva un suo ospedale, intra moenia. E’ da pensare quindi che gli ospedali fossero pertanto due; uno dentro la cinta muraria e l’altro, fuori.
Il 23 giugno 1606, il notaio Donato Antonio Ciracì, in un suo atto ci conferma l’esistenza di un Venerabile hospitale efficiente e funzionante.
Sappiamo pure che il 20 febbraio 1743 il Salento fu colpito da un disastroso terremoto. Tutte le città della zona subirono ingenti danni. E Ceglie non fu certo da meno, il nosocomio cegliese in quell’occasione deve aver subito gravi danni alle infrastrutture tanto che il 2 dicembre di quello stesso anno (1743) si rese indispensabile la………ristrutturazione e riedificazione…… dello ospedale. Ma già nel 1744 il cronista domenicano scriveva di un “vecchio ospedale”.
Qual’era dunque l’ubicazione di quel vecchio ospedale? Non certo quello che noi conosciamo con quel nome, né tanto meno quello ubicato nell’abbattuto convento dei frati Cappuccini. Quello diventò ospedale cittadino a seguito dell’epidemia di colera del 1866. Dopo la cacciata dei frati avvenuta il 31 dicembre 1865 era stato trasformato in ricovero di mendicità
Un atto del notaio Tommaso Lamarina, datato 12 aprile 1683, riporta l’inventario dei beni immobili di proprietà della Cappella di Sant’Antonio di Vienna situata dentro la Terra dei Ceglie. Beneficiario di detti beni (Grància o Beneficio) era il clerico Giuseppe Oltavy della Terra di Turris Paludarum (odierna Torrepaduli, prov. di Lecce), diocesi di Ugento. In seguito, nel 1748, quel Beneficio veniva goduto, invece, dal Cappellano rev. Don Giuseppe Manfredi di Scorrano (LE), il quale fu investito dal Cardinale Francesco Pignatelli, arcivescovo di Napoli (Napoli 6.2.1652 – ivi 5.12.1734). Fu arcivescovo di Taranto dal 27.9.1683, Nunzio apostolico in Polonia fino al 1703). Ma perché i Cappellani di quella Cappella erano della provincia di Lecce? Non mi è stato possibile saperlo.
Il Sant’Antonio di Vienna in questione, altro non era che il nostro Sant’Antonio Abate. Così veniva indicato perché le reliquie del Santo erano custodite, in Francia, nella Chiesa di Sant’Antoine de Viennois. Nel nostro dialetto il Santo viene ancora oggi indicato con la pronunzia francesizzata : Sant’Anduèn.
Sant’Antonio Abate fu venerato dal popolo, il quale faceva ricorso a lui contro la peste, lo scorbuto e contro tutti i morbi contagiosi. Lo sviluppo del culto popolare del Santo fu dovuto alla sua fama di guaritore dell’Herpes zoster meglio conosciuto come fuoco di Sant’Antonio.
L’origine di questa tradizione risale alle molte miracolose guarigione che sembrano essersi verificate durante un’epidemia che infestava la Francia in occasione della traslazione delle reliquie del santo da Costantinopoli in Europa. In onore di Sant’Antonio Abate, il giorno della vigilia della festa (16 gennaio) venivano e tuttora vengono accesi per le strade dei centri abitati dei grossi falò. Nel brindisino, per esempio, questa tradizione è molto sentita a San Vito dei Normanni, a San Michele Salentino, a Francavilla Fontana, ecc.
La popolarità del culto favorì la pia consuetudine di intitolargli ospedali, chiese, confraternite, edicole. Il suo culto, in Oriente, risale al IV secolo, in Occidente al V, a Ceglie, in particolare, nella notte dei tempi, ma mai prima del V secolo.
Il Santo, inoltre, è il protettore degli animali domestici. Il 17 gennaio, infatti, giorno della festività del Santo, sul sagrato delle chiese vengono benedetti gli animali domestici ed il pane, cosiddetto di Sant’Antonio, da far mangiare agli animali domestici malati (Biblioteca Sanctorun,Roma 1962, pp.115-116).
Non sappiamo se nella vecchia Chiesa Matrice, quella ristrutturata nel 1521 dai coniugi Sanseverino, si venerasse il Santo di Padova. Troviamo le prime notizie certe solo nel 1630, quando il Duca Diego Lubrano fece costruire una Cappella dedicato al Santo riservandosi lo Jus Patronatus, ossia il diritto farsi ivi seppellire insieme ai suoi cari. Cappella tuttora esistente nella Chiesa Madre. Trattasi dell’altare laterale ancora dedicato al nostro Santo Patrono.
Anche Sant’Antonio da Padova ha per tradizione il cosiddetto pane dei poveri. Una pia devozione ed istituzione questa di notevole rilevanza sociale consistente in una elemosina distribuita ai poveri sotto forma di pane. La benefica opera a sollievo dei poveri ebbe sviluppo alla fine del XIX secolo per merito di Louisse Bouffer di Tolone in seguito ad una speciale grazia da lei ottenuta.
L’Amministrazione comunale cegliese in data 14 marzo 1823 chiese al Vescovo di Oria il permesso di festeggiare Santo Antonio da Padova il giorno della sua ricorrenza (13 giugno), e non la domenica successiva come era stato fatto fino a quel momento.
Per quanto sopra esposto, devo ritenere che la famosa Cursìa Sant’Antonio potrebbe, dico potrebbe, riferirsi a Sant’Antonio Abate venerato fin da alcuni secoli prima di Sant’Antonio da Padova.
