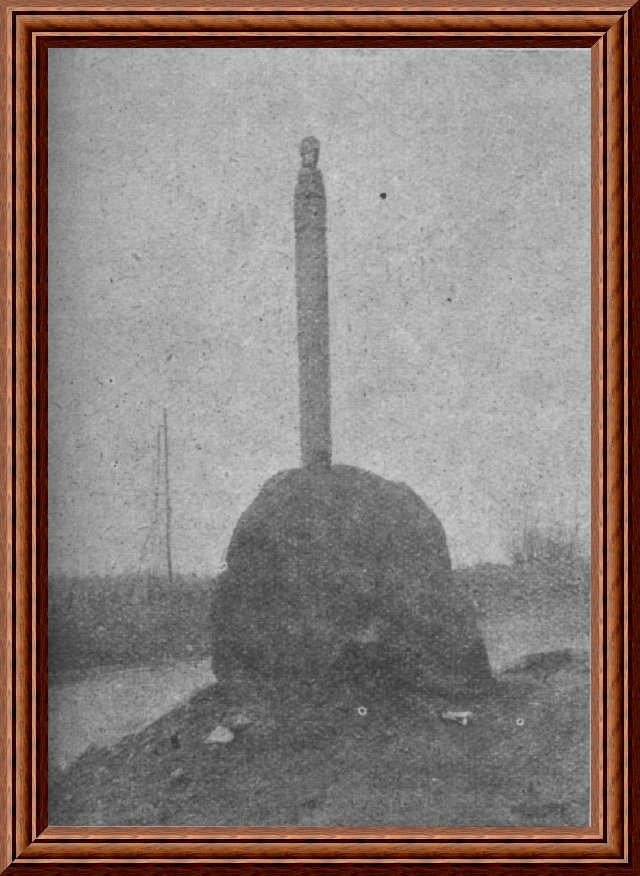La simbologia del pellicano è la colomba furono incisi sulla croce bianca ancorata alla sommità della stele ottagonale di Sant’Antonio di Ranverso.
La simbologia del pellicano è la colomba furono incisi sulla croce bianca ancorata alla sommità della stele ottagonale di Sant’Antonio di Ranverso.
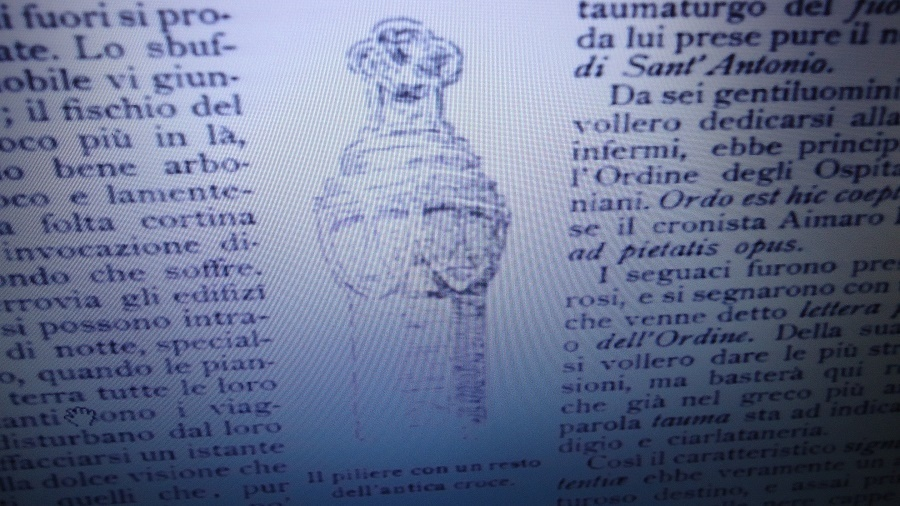
La Simbologia:
Sembra che l’uccello bianco d’Egitto con questo nome, dal caratteristico lungo becco, nutrendo attraverso un’apertura del collo i suoi piccoli, abbia dato luogo alla leggenda del sacrificio delle proprie carni per la vita dei figli fino a divenire “emblema di carità” (O. Wirth) ovvero di devozione parentale fino al sacrificio. Più realisticamente, l’incurvare del becco verso il petto per cibare i piccoli con pesci trasportati nella sacca indusse a credere che addirittura l’animale si squarciasse il petto per dare loro nutrimento col proprio sangue. L’analogia di forme e affilatura del becco e scure, l’assonanza con le parole greche e sanscrite con il significato di ascia (pelekus e paraçu rispettivamente), segno simbolico del sacrificio di sangue, potrebbe far risalire l’origine della leggenda a tempi antichissimi. Il reperimento di sue rappresentazioni in epoche assai diverse, dalla scultura messicana in pietra vulcanica del 600-1000 d.C. ai numerosi riscontri europei non solo medievali, dimostra la sua rilevanza simbolica



Dal Bestiarum Christianum: Pellicano
Il pellicano compare solo una volta nell’Antico Testamento (Salmi, 102.7) e non viene mai nominato nei Vangeli. Troppo poco forse per meritare la citazione nel Dizionario delle immagini e dei simboli biblici delle Edizioni Paoline, che non ne riporta alcun cenno. Si deve soprattutto al Physiologus (II-IV secolo?) – il pellicano è al n°4 del suo inventario – la diffusione della leggenda, in termini alquanto più complessi; narrando della resurrezione dei piccoli (dopo tre giorni) ad opera della madre, che li ha uccisi, vi è l’adattamento diretto alla simbologia di Cristo “che è salito alle altezze della Croce e dal suo fianco aperto sono sgorgati il sangue e l’acqua per la salvezza e la vita eterna”. Oltre a Dante, anche S.Tommaso d’Aquino (“il pio pellicano”) usa l’allegoria. Ulteriori riscontri si trovano in Michael Glychas e in vari “bestiari” medievali, fino alle ultime rivisitazioni del XVIII secolo (cfr stampa a colori dell’epoca pag, 155, L’Arte dorata, A. de Pascalis). Echi dell’antica credenza si possono ancora trovare in alcuni adornamenti dell’arte religiosa cristiana nei luoghi più vari, come, ad esempio, in un rilievo del Duomo di Münster (1235) e, più vicino a noi, in una statua sul frontone della Chiesa della Maddalena in Castelnuovo Magra. Un’incisione – affascinante nella sua essenzialità – su un elemento lapideo del cornicione dell’abside della Chiesa di S. Felicita, in località Prelerna nel Comune di Solignano (PR) riproduce con chiarezza il pellicano nell’atteggiamento più classico del becco contro il petto. Probabilmente la pietra è stata riutilizzata dai resti di un antico convento di Gesuati e, quindi, può farsi risalire circa al 1400. Anche opere di arredo sacro contemporanee a carattere artigianale rappresentano il pellicano (Chiesa di Valletti nel Comune di Varese Ligure). Un’estensione ermetica della leggenda, attraverso la simbologia della materia humida, che scompare con il calore solare per rinascere d’inverno, ricollega il pellicano al sacrificio di Cristo ed alla sua resurrezione, ma anche a quella di Lazzaro, tanto da accoppiare talora l’immagine del pellicano con quella della fenice. Ciò avviene anche per i Moderni. E. Minguzzi (Alchimia, il cammino della potenza) illustra il mito della Fenice con con la stessa immagine rosicruciana del pellicano impiegata per ben due volte nello stesso testo da O. Wirth (Il simbolismo ermetico) per commentare il significato del pellicano. Ma i molti figli possono essere scambiati per fiamme… Peraltro nella Sapientia veterum philosophorum sive doctrina eorundem de summa et universali medicina del XVIII secolo pellicano e fenice compaiono rispettivamente nella figura XXVII e XXVIII per rappresentare exaltatio essentiae e essentia exaltata. Analoga contiguità e consequenzialità si notano fra il pellicano e la fenice, rispettivamente immagini n° 46 e 47 nella decima delle diciassette figure attribuite a J. C. Barchusen (databili tra il 1615 e il 1635) e nella tavola “Basilicae Philosophicae” della “Cosmologia alchemico-rosacruciana sulla visione dell’unità“, Museum Hermeticum, Frankfurt a.M., 1677. Come dice il Fisiologo, dal fianco aperto del Cristo sono sgorgati il sangue e l’acqua per la salvezza eterna. Tale analogia tra piaga del Crocefisso e petto squarciato del pellicano sono stati ripresi anche da Silesius. Si riscontrano echi anche al di fuori della simbologia religiosa. In letteratura, il mito viene ripreso dal Pulci mentre a Palazzo Ducale di Venezia gli intarsi del capitello della penultima colonna verso il ponte della Paglia rappresentano pellicani. Di tutto ciò ben poco permano in quella che oggi chiamano coscienza collettiva.
Dal Bestiarium Alchemicum:
Il Bestiario Alchemico offre numerosi riferimenti al pellicano, alcuni dianzi citati, sia per indicare gli strumenti dell’Arte sia per la simbologia delle fasi dell’Opera, sia, ancora, per quella elementale. Nei simboli alchimici (P. Bornia, La Porta magica di Roma), il Pellicano indica il matraccio, con il caratteristico piede di collegamento alla testa della cucurbita e con il capitello che rientrava con un tubo a becco nella parte inferiore dell’apparecchio (pallone). Il tubo poteva essere raddoppiato, modificando lo strumento in due palloni comunicanti per ottenere la “circolatio” doppia. Il Pellicano o Pelicano, serviva dunque nella coobazione di un liquido. Una precisa definizione si trova anche in Alchimia Spirituale di R. Ambelain, ove, per la sua funzione, viene anche chiamato “circolatorio”. Trattasi tuttavia di strumento non comune, certo non impiegato dai soffiatori. Infatti non è rintracciabile nelle immagini pervenuteci dei laboratori alchimisici, quali il disegno di Bruegel il vecchio (1558) e di H. Weiditz (1520), la tela di H. Heerschop (1687), il dipinto di J. Van Der Straet detto Stradanio (1570) nè nelle tavole illustranti la strumentazione chimica antiquaria, nè nella farmacia spagiria (Castel S. Angelo, 1600). Il Wirth spiega il simbolo del pellicano come emblema di generosità assoluta “in mancanza della quale, nell’iniziazione, tutto resterebbe irrimediabilmente vano”. Per altri sarebbe un’immagine delle pietra filosofale che si dissolve per far nascere l’oro dal piombo allo stato fluido, cui corrisponde l’aspirazione non egoistica (il pellicano divora il pesce strettamente necessario alla vita). Con ciò sono da riconnettere, forse, antichi gradi di società iniziatiche come il cavaliere di pellicano (cfr. H. Biedermann, Enciclopedia dei Simboli), e la sua effige nel Capitolo dei Rosacroce (L. Troisi, Dizionario dell’esoterismo e delle religioni). Il pellicano compare tra altri simboli nella sintesi dell’Opera illustrata dalla f.92 del Rosarium philosophorum di Arnaldo da Villanova. I Saggi preferiranno meditare sulla figura 6 di J. D. Mylius (Philosophia reformata, Francoforte, 1622), ove un pellicano con i figli è prossimo a un pozzo in cui stanno immergendosi (o da cui stanno fuoriuscendo?) bizzarre figure solari; nello sfondo centri edificati. Esse richiamano al Filosofo il terzo sonetto di Frate Elia (Biblioteca nazionale, manoscritto Magliabechiano, II-III-308 a carte 39) “…in humidum ponite ut unidetur optime“. In effetti il pellicano simboleggia anche il Mercurio dei Filosofi, “il solfo precipitato, ovvero il principio dello stato liquido della materia” (G. Testi), ovvero “l’acqua segreta”. Osservazioni conclusive Un panorama vasto di iconografia e di arte, cronologicamente estesa su vari secoli, si richiama all’immagine del pellicano, con simbologie dai molteplici significati. Uno sguardo più attento sulle vestigia d’arte, non solo sacra, potrebbe far riscoprire al Saggio qualche altro pellicano, rimasto inosservato, strumento di Tradizione.
In araldica il pellicano è simbolo di pietà, amore e carità per il prossimo e, in quanto tale, è rappresentato sempre nell’atto di lacerarsi il petto per nutrire i suoi piccoli. Tale immagine è detta pellicano con la sua pietà.
La simbologia deriva dal fatto che la femmina nutre i piccoli stritolando i pesci che tiene a macerare nella sacca membranosa che pende dalla mandibola inferiore. Quindi preme il becco contro il petto e ne fa uscire il cibo, dando così l’impressione che si trafigga il petto per farne uscire il sangue con cui nutre i piccoli.
Questa leggenda ha ispirato anche il simbolo di Cristo che versa il sangue per la redenzione degli uomini ed è, quindi, rappresentato anche come un pellicano con la sua pietà.
- Commenti disabilitati
TRANSLATOR
CATEGORIE
Seleziona una categoria AUDIO CHIESE PRECALCEDONIANE CROCIATE DELLA PREGHIERA CURIOSITA’ DECRETI E PROVVEDIMENTI DOWNLOAD I MIRACOLI DI GESU’ I RE MAGI IL PELLICANO LA NOSTRA STORIA MIRACOLI ORDINE PREGHIERE REGOLE SIMBOLISMI & SIMBOLOGIE UR VIDEO
LINKS
- BENEDICTUS XVI
- Blog di AURELIO PUNZO LOPEZ
- CONOSCENZE STORICHE
- Ecclesia Vetero-Catholica Romana
- i cavalieri del tempio
- IMITAZIONE DI CRISTO
- LA VERA STORIA DI BABBO NATALE DEDICATA AI BAMBINI
- MARIA DI NAZARETH
- MONASTERO VIRTUALE
- Pie Pellicane Jesu Domine di S. T. D’Aquino
- Pieta del Pellicano
- S. Bernardi abbatis primi Clarae-Vallensis opera omnia
- SANTI E BEATI
- TE ADORO AMOROSO MP3
- VISITA I LUOGHI RELIGIOSI DI GERUSALEMME
- VISITA IL SITO DELL’ORDINE
IMPORTANTI
Seleziona il mese Dicembre 2020 (1) Novembre 2017 (1) Settembre 2017 (2) Gennaio 2017 (1) Dicembre 2016 (2) Novembre 2016 (1) Ottobre 2016 (1) Aprile 2016 (4) Dicembre 2015 (4) Ottobre 2015 (3) Settembre 2015 (10) Agosto 2015 (2) Luglio 2015 (6) Giugno 2015 (10) Maggio 2015 (2) Aprile 2015 (5) Marzo 2015 (2) Febbraio 2015 (1) Dicembre 2014 (5) Novembre 2014 (12) Ottobre 2014 (9) Luglio 2014 (1) Maggio 2014 (1) Aprile 2014 (1) Febbraio 2014 (3) Gennaio 2014 (2) Dicembre 2013 (1) Ottobre 2013 (2) Settembre 2013 (1) Luglio 2013 (1) Maggio 2013 (4) Aprile 2013 (2) Marzo 2013 (4) Febbraio 2013 (12) Settembre 2012 (1) Giugno 2012 (2) Maggio 2012 (1) Aprile 2012 (1) Marzo 2012 (3) Febbraio 2012 (1) Gennaio 2012 (15) Maggio 2009 (1)
CURIOSITÀ RELIGIOSE, PASQUA, SACRAMENTIIl significato simbolico della colomba Scritto da Myriam il 30 Settembre 2019 6 min di lettura
La colomba è uno dei simboli cristiani più conosciuti, presente nei momenti più salienti della religione cristiana e simbolo di numerose celebrazioni. Nel Libro della Genesi, quando si racconta la storia di Noè e del Diluvio Universale che ricoprì la terra per quaranta giorni e notti, fu proprio grazie a una colomba che Noè riuscì a trovare la strada per la salvezza.
Si tratta di un simbolo molto importante che rappresenta la purezza della fede e dell’animo cristiano.
In questo nuovo articolo vogliamo raccontarti qualcosa in più sul significato della colomba e in che modo si lega alla storia della religione cristiana. Continua a leggere!
Cosa rappresenta la colomba bianca?
Abbiamo iniziato il nostro articolo raccontandoti la storia di Noè e del Diluvio Universale. Ebbene, dopo quaranta giorni e notti in balia del mare, del vento e della pioggia, poco prima che comparisse la terra ferma, Noè fece volare un corvo per ricevere indicazioni sulla rotta da percorrere. Il corvo non fece mai ritorno. Così provò con una bella colomba bianca. Pochi istanti dopo averla liberata in volo, la colomba tornò portando con sè il famoso “ramoscello d’ulivo” per indicare la via verso la terra e la salvezza.
Anche nel Nuovo Testamento la colomba compare simbolo dello Spirito Santo. Nel Battesimo di Gesù infatti, quando Giovanni Battista celebra il sacramento, la colomba va ad appoggiarsi sul suo capo a indicare che lo Spirito Santo era sceso su di lui.
Anche negli Atti degli Apostoli la colomba rappresenta lo Spirito Santo, nonostante quando apparve questo si presentò sotto forma di lingue di fuoco posate sul capo degli apostoli e del popolo cristiano.
Nell’immaginario comune, la colomba rappresenta la purezza e candore, grazie al suo colore bianco proprio come il colore dell’abito indossato dal papa così come dalla sposa nel giorno delle nozze.
La colomba in Palestina
In Palestina la colomba è uno degli animali più diffusi e nella Bibbia è senza dubbio l’uccello più menzionato. Anche nelle culture extrabibliche, la colomba era simbolo della divinità e dell’amore. Oltre a incarnare la bellezza, la fedeltà dell’amore e la tenerezza, la colomba è simbolo di purezza, della ricerca di Dio, di libertà e messaggero di pace. (Gn. 8,11.).
Dove compare il simbolo della colomba?


Colomba con Raggiera in Legno Brunito…EUR 109,50
Colomba Spirito Santo con Raggiera…EUR 134,00
Nel Cantico dei Cantici, la colomba viene usata per esprimere l’amore umano puro e fedele. Infatti, la sposa viene spesso chiamata “colomba mia” (1,15;2,14).
Questo animale simbolico ricorda che Dio ha fatto pace con l’umanità peccatrice. Grazie a questa riconciliazione è iniziata una nuova storia, basata sulla fiducia di Dio che non si ferma davanti al male compiuto dall’uomo ma continua a dare prova del suo amore e della sua misericordia. Infatti, con la fine del diluvio si vuole dare una dimostrazione concreta sulla benevolenza di Dio verso l’uomo, creato a sua immagine e perfezione.
Nell’Antico Testamento la colomba che geme simboleggia la persona che vive un momento difficile a causa di una malattia e del dolore. Nel salmo 55,6-7 troviamo scritto: “timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo”. In questi versetti la colomba esprime il popolo di Israele, che fa sentire i suoi gemiti di dolore che, come una colomba, sono in attesa di ricevere in dono la salvezza.
La colomba è inoltre simbolo di gioia. Come si legge in Osea 11,11: “Accorreranno come uccelli dall’Egitto, come colombe dall’Assiria, e li farò abitare nelle loro case”. Ma è anche segno di ingenuità e semplicità. In Osea la colomba rappresenta la tribù di Efraim che, priva di intelligenza (7,11_12), ha confidato prima nell’Egitto poi negli Assiri.
La colomba è presente anche nel Nuovo Testamento. Come animale bianco e puro era destinata al sacrificio, e veniva offerta al tempio dagli israeliti (lc, 2,22-24), come offerta dei poveri ( Lv 1,4; 12,6.) durante i riti di purificazione. I vangeli testimoniano l’ira di Gesù contro i venditori di colombe, che iniziarono a creare un commercio di questi uccelli simbolici accanto al tempio (Gv 12-25).
Come anticipato, la colomba è presente nel Nuovo Testamento durante il battesimo di Gesù sul fiume Giordano. Il significato è quello di un nuovo inizio, l’anno della misericordia del Signore che inaugura, come in occasione del diluvio, una nuova creazione. Proprio come all’inizio della creazione, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, trasformando in vita il caos originario.
Anche Gesù usa l’immagine della colomba, abbinata a quella del serpente: “prudenti come serpenti, semplici come le colombe” (Mt 10,16). Si tratta di due virtù per certi versi contrarie ma entrambe necessarie. L’intelligenza infatti, non è solo astuzia volta a ingannare, come fece il serpente in Genesi 3, ma è anche prudenza utile per scoprire l’inganno e sottrarsi ad esso. Allo stesso modo anche la semplicità non è mancanza di accortezza di chi si espone al pericolo senza prudenza, ma va intesa come la fiducia del bambino che si affida alla madre, una persona che mai potrà tradirlo o ingannarlo.
Il cristiano quindi è sempre combattuto tra il serpente, una figura intelligente e terra terra, e la colomba, che vola libera nei cieli. Quando il fedele è troppo serpente viene schiacciato nella polvere, se invece è troppo colomba evapora. È un gioco di equilibri tra due polo antinomici e inconciliabili, che sottopongono il cristiano ad una tensione continua. E forse è proprio questo che rende il fedele attivo e luminoso come la luce che si viene a creare quando sono presenti due poli elettrici opposti. La luce che anima la fede in Dio. Un solo polo infatti, anche se molto potente non è in grado di produrre nulla. Ed è solo grazie a questo gioco continuo che il cristiano può sentirsi ricco e fecondo.
Per capire cosa simboleggia la colomba nella tradizione cristiana è necessario aprire la mente a molteplici interpretazioni. Purezza, semplicità, salvezza, forza, ingenuità, leggerezza, tanti significati che permettono di raccontare la grandezza di un animale così indifeso.
Sei rimasto affascinato dal significato che racchiude la colomba dietro le sue candide piume bianche? Sul nostro sito puoi trovare numerosi accessori che la ritraggono e che puoi tenere sempre con te o regala a una persona cara, per ricordare la purezza della fede in Gesù. La colomba è un regalo perfetto per un giovane ragazzo che si avvicina alla Santa Cresima, come simbolo dello Spirito Santo. Visita la pagina dedicata agli oggetti e articoli per la Cresima!
LEGGI
PAGINE
ARTICOLI RECENTI